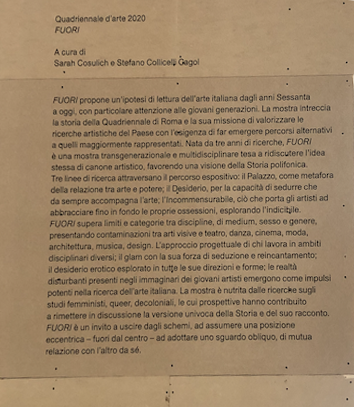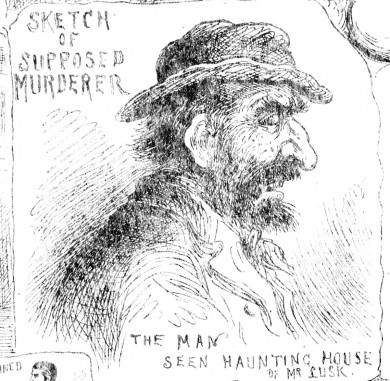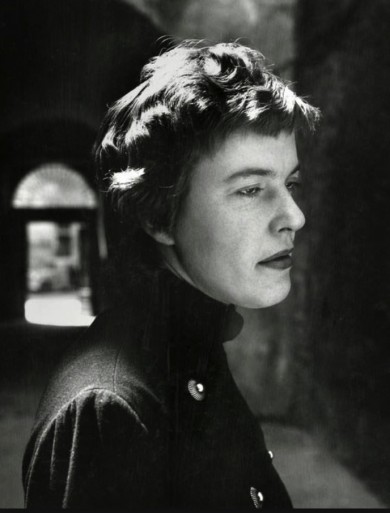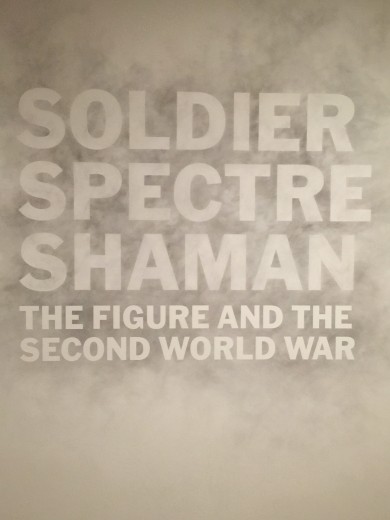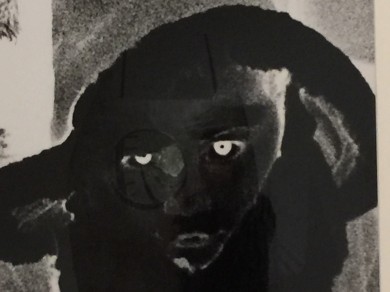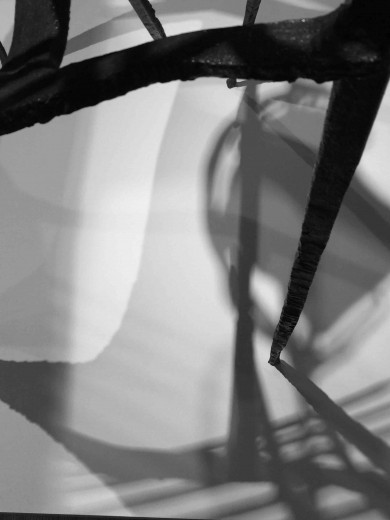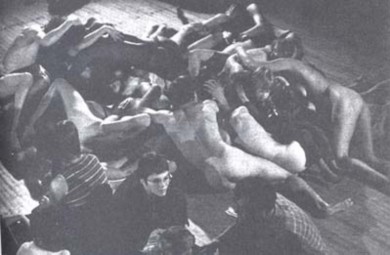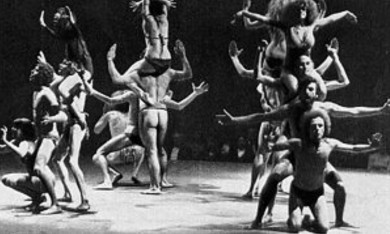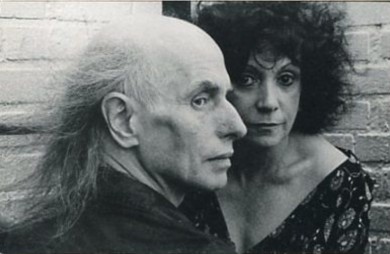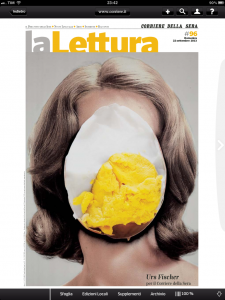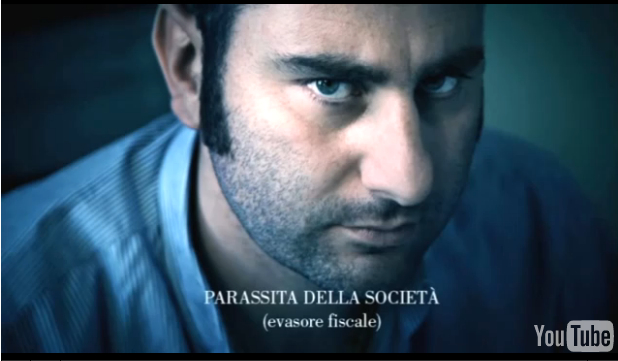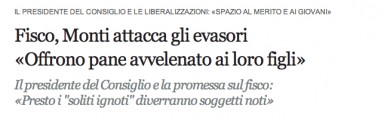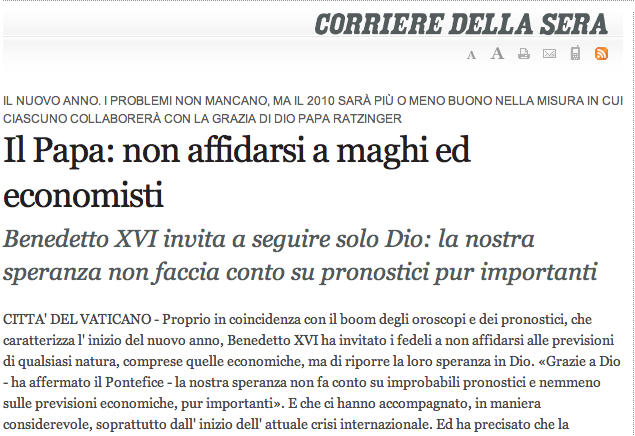Nomadi
Molti anni fa, Jean Baudrillard scrisse un breve articolo sui graffiti a New York. Erano un tentativo di spezzare l’ordine razionale della griglia geometrica di quella metropoli. Smagliature visive nell’ordine ferreo e numerico di una trama di coordinate cartesiane che non consentono mai di perdersi.
Vincenzo Padiglione, artista in quanto antropologo, interpreta allo stesso modo la Wunderkammer. Tuttavia la trasferisce dalla ‘meraviglia’ alla ‘curiosità’, cabinet de curiosités, come suona un’altra dizione. (continua)